tempo di lettura 11′
Loro (gli ingegneri) l’hanno sempre saputo. Che, a fare una misurazione, non è che ci si azzecchi sempre. Men che meno al primo colpo. In genere, l’esito dell’operazione non coincide esattamente con il vero valore da misurare (qualunque cosa intendiamo per vero). Lo scarto tra i due valori è ciò che chiamiamo errore. Ma gli ingegneri sono anche abituati a distinguere due componenti dell’errore, che originano da cause diverse, e soprattutto richiedono logiche differenti nell’affrontarli: errori casuali ed errori sistematici.
Errori casuali
Il primo, il più immediato da comprendere, è quello che fa sì che ogni singola misurazione dia risultati leggermente diversi ad ogni replica: un fatto comune, spiegabile in termini di variabilità statistica. Un mediocre giocatore di basket, su cento tiri ne spedirà alcuni fuori bersaglio, molti sul cerchio di ferro o sul tabellone (ma tipicamente in punti diversi), e qualcuno direttamente in rete. Un giocatore più preciso (è il termine appropriato) vedrà i suoi tiri finire ancora in punti random, ma distribuiti su un’area più ristretta (ad esempio, non al di fuori del ferro), e otterrà quindi una percentuale di canestri più alta. L’esito reale dipenderà da mille fattori ineffabili che casualmente porteranno la palla ora qualche centimetro più a destra, ora appena troppo lontano. Si tratta di errori casuali (noise o, in italiano, rumore). Creano certo qualche problema (non tutti i tiri finiranno in rete). D’altra parte, le variabili in gioco sono talmente numerose che non riusciamo ad attribuire a questi errori una causa comune a tutti. Né, per la stessa ragione, siamo in grado di prevederedove esattamente finirà il tiro successivo. Sappiamo solo che, in media, i tiri saranno distribuiti più o meno intorno al centro della rete. Fuor di metafora, solo processando un certo numero di misure (ad esempio mediandole) potremo avvicinarci al valore vero.
Errori sistematici
Ma immaginate un giocatore molto preciso, che cioè tira sempre la palla in un intorno ristretto dello stesso punto. Punto che, però, è a una ventina di centimetri a sinistra del centro del canestro. Tutta la sua precisione non gli servirà a molto, perché, in media, la palla finirà sul ferro, ma solo qualche volta rimbalzerà nel canestro. Un giocatore preciso, dunque, ma poco accurato. Soggetto, possiamo dire, a un significativo errore sistematico. Nel suo caso, non sarà difficile prevederedove finirà il prossimo tiro (sul ferro, a sinistra). Inoltre, la ripetitività degli esiti potrebbe suggerire a un buon coach che ci siano delle solide ragioni a spiegare questi errori sistematici (una contrattura temporanea? Un difetto di postura?), e come eventualmente intervenire sulle cause (o, alla peggio, consigliare al giocatore di mirare venti centimetri più a destra di quanto gli verrebbe da fare).
Come vedete, gli errori sistematici lasciano qualche speranza di essere individuati e corretti. Quelli casuali, invece, appartengono a una categoria rognosetta, sulla quale però si sono esercitati secoli di statistica, e di evoluzione tecnologica.
Non è dunque un caso che, nella storia delle scienze occidentali, la ricerca di una precisione crescente abbia costantemente accompagnato il loro progresso.
Ma, nello sviluppo della psicologia, le cose sono andate diversamente. Forse perché la dimensione quantitativa si è sviluppata molto tardi rispetto alle scienze dure. Forse perché i primi ad occuparsi seriamente dell’errore nel giudizioprima, nella decisione in condizioni di incertezza più tardi, si sono concentrati su deviazioni sistematiche dalle teorie classiche della razionalità: i cosiddetti bias cognitivi. Come sappiamo, sono la loro universalità e inconsapevolezza a renderli pericolosi. Ma è proprio la loro sistematicità a metterli in condizione di essere, quanto meno, <trattabili>: sono riconoscibili, generano comportamenti prevedibili, sono suscettibili di interpretazioni causali.
Negli ultimi decenni, gli errori sistematici (bias) si sono presi decisamente il centro della scena della ricerca (e ormai della moda) psicologica. Relegando quelli casuali a note a piè di pagina nella letteratura sugli errori del giudizio e della decisione. Intendiamoci: i bias creano un sacco di guai. Ma il rumore (come d’ora in poi chiameremo la componente casuale, o noise) non è da meno.
Che significa rumore nella vita personale o organizzativa?
Che la stessa situazione riceve valutazioni diverse da persone diverse. Anche quando si tratta di esperti, di professionisti. Avete presente quando, consultando un nuovo medico alla ricerca di un secondo parere, vi ritrovate con una diagnosi radicalmente diversa dalla prima (mi è successo personalmente)? Forse possiamo aspettarcelo in campi in cui la valutazione soggettiva è particolarmente rilevante (psichiatria, psicoterapia); ma che dire quando due medici reclamano interpretazioni opposte della stessa biopsia, o di una medesima lastra radiografica? Rumore è anche quando chiedete il calcolo dell’IMU, e due commercialisti diversi vi faranno versare cifre diverse (sì, mi è capitato anche questo). O, infine, quando lo stesso candidato viene valutato diversamente da selezionatori differenti (o diversi candidati ricevono giudizi incoerenti da parte dello stesso selezionatore). Niente, peraltro, in confronto a ciò che accade in campi ancora più sensibili, e magari più soggettivi nell’interpretazione: le previsioni economiche, o di mercato; o, peggio ancora, le sentenze penali. Il rumore può far male.
Come i bias cognitivi, anche il rumore presenta caratteristiche peculiari. Entro certi limiti, è un fatto del tutto naturale. I giudizi, specialmente in certi campi, sono difficili, complicati, in qualche misura necessariamente soggettivi. Non deve stupire dunque una certa variabilità, anche tra esperti. Quello che spesso sorprende, tuttavia, è l’entità del rumore che incontriamo, quando ce ne accorgiamo. Come la stupidità umana per Carlo Maria Cipolla, il rumore è sempre più grande di quanto ci immaginiamo. E, di conseguenza, inaspettata è l’entità dei guai, delle diseguaglianze, dei costi che può generare. Infine – la buona notizia – è possibile ridurre il rumore, e abbiamo a disposizione più di una tecnica per farlo. Solo che – questa è la cattiva – difficilmente riusciamo ad attuarle senza sollevare un polverone di obiezioni e ostacoli di ogni genere. È questo il vero target da puntare.
A tentare di sovvertire la dittatura mediatica e accademica dei bias, sono due giganti (e mezzo) che hanno tanto contribuito al loro stesso successo: Daniel Kahneman (psicologo e Nobel), Cass Sunstein (giurista e intellettuale a tutto campo) e Olivier Sibony (McKinsey), con un magnifico libro uscito lo scorso anno: Noise: a Flaw in Human Judgment.
Che tipo di conseguenze possono derivare dal rumore?
Quando non venga opportunamente contrastato? Almeno due. Una è l’aumento della diseguaglianza, la riduzione dell’equità sociale (o organizzativa). Sunstein (e chi altro? È del mestiere) punta, ad esempio, il dito sulla realtà del sistema penale statunitense, dove un’estorsione, a seconda del giudice con cui capiti, può costarti sedici anni di prigione, con 65.000$ di multa; oppure soltanto tre anni di carcere, senza multa. Ma tutto il mondo è paese; e studi rigorosi dimostrano che, in altri Paesi, le decisioni sui malcapitati variano notevolmente a seconda che il giudice abbia pranzato o sia a ridosso di un break, che sia il compleanno dell’imputato o meno, che il clima sia caldo e umido, o che la squadra del cuore del giudice abbia vinto o perso nello scorso week-end.
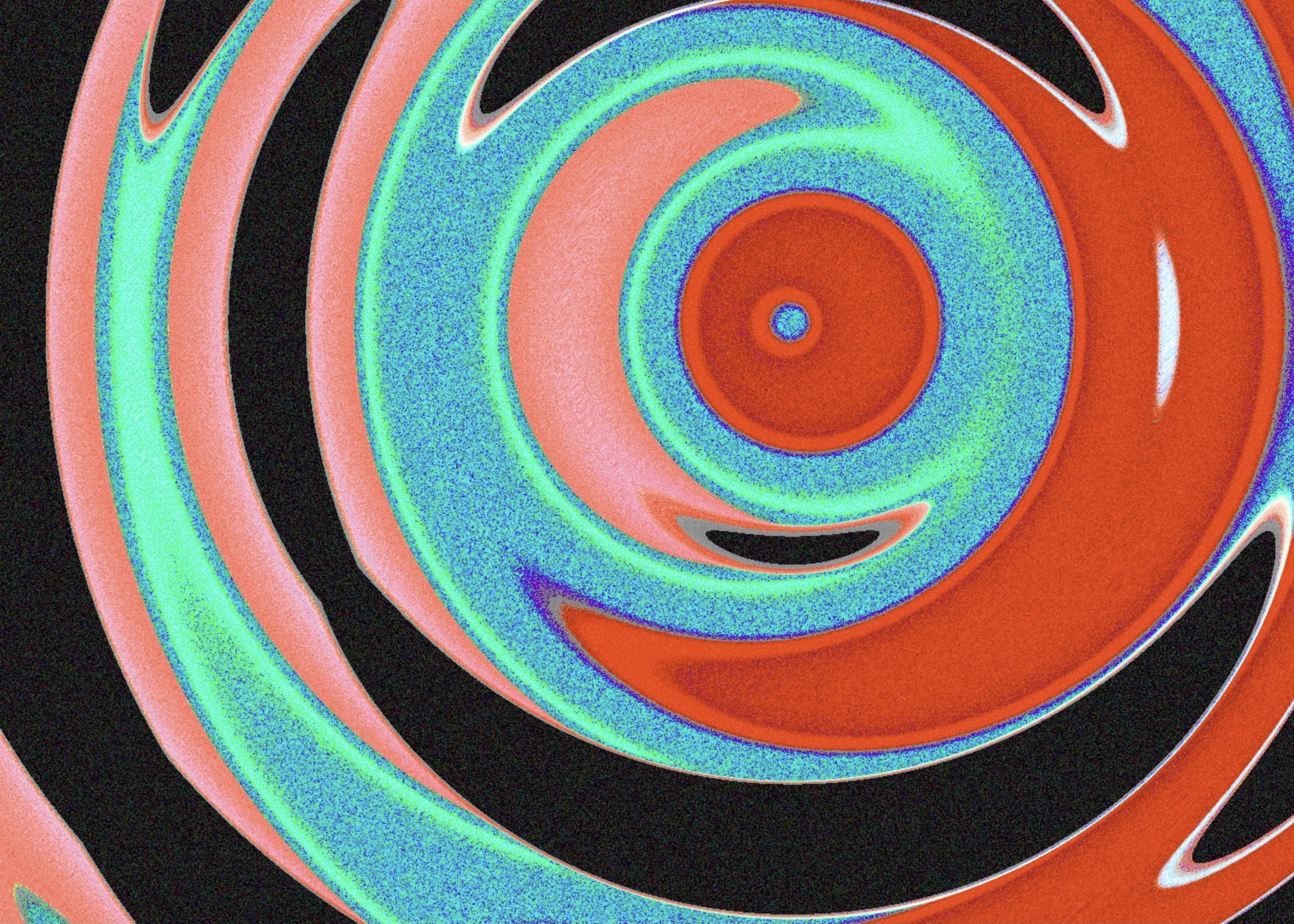
Un esempio di rumore: le assunzioni
Però ci sono anche conseguenze di carattere economico. Un esempio, che i tre autori citano, e di cui potete direttamente verificare gli impatti per la vostra organizzazione, è la selezione del personale, di cui ho scritto qualche tempo fa (State assumendo? Date un’occhiata a questi bias | LinkedIn). In quell’articolo, rammentavo come l’hiring sia un campo minato, disseminato di bias cognitivi di ogni tipo. Molti di essi in particolare infestano quello che a tutti gli effetti è considerato uno strumento imprescindibile quando si parla di selezione: l’intervista non strutturata. Nonostante si tratti di un argomento su cui si è cominciato ad indagare circa un secolo fa, e sia probabilmente il tema di decision making più studiato di sempre, Kahneman e i suoi colleghi partono da una notizia che ci lascia francamente un po’ interdetti. Se il vostro obiettivo è determinare quale candidato avrà successo nel nuovo lavoro, e quale fallirà, lasciate perdere le interviste standard. Per dirla tutta, servono a poco o nulla. Un duro colpo per il nostro amor proprio. Eppure una serie interminabile di studi vi confermerà che, se l’unica informazione a disposizione per scegliere un candidato è che un’intervista non strutturata vi fa preferire A piuttosto che B, la probabilità che A performi meglio di B è di poco superiore al proverbiale lancio della monetina (tra il 56 e il 61%): non proprio il genere di rassicurazione a cui punteremmo per prendere una decisione critica per la nostra organizzazione.
Ma perché?
A parte l’incertezza che avvolge qualsiasi essere mortale (incluse le vite future dei candidati), esistono, come abbiamo visto, ragioni sistematiche, che spingono cioè tutte nella stessa direzione, a deviare i giudizi di persone diverse. Sappiamo ad esempio che c’è un bias (in-group bias) che spinge le persone a preferire (e favorire) altre persone appartenenti al loro stesso gruppo (sociale, familiare, culturale, sportivo, ecc.). Conosciamo anche gli impatti dell’effetto alone (estendiamo il nostro giudizio positivo o negativo da una caratteristica della persona alla sua totalità), e in particolare di quella sua variante ubiqua che prende il nome di beauty bias (credo non richieda spiegazioni). Nell’articolo ho elencato un’altra decina di bias che vi aspettano in agguato nelle varie fasi del processo. Tutte forme di distorsione sistematica del giudizio.
Ma certo non ci facciamo mancare il contributo del rumore. Facciamo intervistare un candidato da più intervistatori in sequenza, o in occasioni diverse? Troveremo, con ogni probabilità, valutazioni piuttosto diverse (con indici di correlazione piuttosto modesti, intorno a .40 – .44). Direte: certo, ogni intervista è diversa dall’altra, come un punto del fiume non vede mai due volte la stessa acqua. Ovvio che i giudizi non possano coincidere alla perfezione. Provate allora a realizzare una panel interview, in cui tutti gli intervistatori vedono esattamente le stesse cose. Un po’ meglio, ma anche questa volta non supereremo una correlazione di .74. Ancora una volta, perché?
Ancora una volta, una parte della spiegazione è banale: ognuno di noi reagisce alla sua maniera a intervistati diversi. Così, come siamo costretti a mediare tra misurazioni diverse per raggiungere risultati attendibili, le organizzazioni sottopongono i candidati a colloqui con intervistatori diversi, con l’idea di comporre successivamente gli esiti (un’idea del tutto irta di difficoltà, peraltro).
Ma un altro bias, cui abbiamo accennato nell’articolo citato, provvede a portare a spasso i nostri giudizi, generando una girandola di risultati diversi. Il primacy bias fa in modo che le raccomandazioni di assunzione tendano spesso a rispecchiare le impressioni che abbiamo ricevuto nei primi momenti di convenevoli che precedono l’inizio dell’intervista stessa. Non esiste una seconda possibilità di fare una prima impressione. A questo proposito, un colloquio strutturato, con le sue domande predeterminate, ha qualche possibilità di tenere, per così dire, la barra dritta rispetto a eventuali influenze della prima impressione sullo svolgersi della conversazione. Ma un’intervista non strutturata tende ad essere facilmente guidata, inconsciamente, in una direzione che sia confermativa, piuttosto che confutativa, delle prime impressioni (il terreno di gioco preferito del temibile confirmation bias). A peggiorare le cose, aggiungete il fatto che gli elementi che influenzano maggiormente le prime impressioni sono quelli, piuttosto superficiali, che potete immaginare:
- estroversione,
- skill verbali,
- magari la postura
Che non sono esattamente i migliori predittori di una buona riuscita nel job (ma a volte sono, purtroppo, solo ottimi predittori delle raccomandazioni di assunzione).
Una volta entrati nel tunnel del primacy effect, ci ritroviamo in un regno magico in cui tutto è possibile; perché non amiamo affatto le ambiguità, le contraddizioni, e l’esserci sbagliati, e siamo disposti a qualunque cosa pur di cucire, intorno al nostro intervistato, un’immagine coerente, che abbia – almeno per noi – perfettamente senso. Magari anche un eccesso del medesimo. Una richiesta speciale ed irresistibile del nostro sistema automatico. E così un cambiamento improvviso del posto di lavoro, sul curriculum, diventa, a seconda della prima impressione riportata, un preoccupante segno di instabilità, o un chiaro indizio di personalità e determinazione. Una lunga pausa nella risposta manifesta una comprensibile serietà nel formulare un concetto importante, o un inquietante momento di indecisione e incertezza.
Tutto ciò, tuttavia, potrebbe in fondo essere rimediato, se non fosse che le altre fonti informative, che ci aspettiamo, nella migliore delle tradizioni, di integrare all’intervista nel gran finale, correggendo eventuali distorsioni – test di varia fattura, lettere di referenza, i curricula stessi – presentano qualche importante limite:
- generalmente non sono qualcosa che possiamo vedere come frutto delle nostre abilità personali, contrariamente alle interviste che sono opera del nostro ingegno (non godono perciò del beneficio dell’endowment effect, un bias che ci spinge, tra l’altro, a sopravvalutare il valore di tutto ciò che possediamo per il semplice fatto di possederlo – ivi incluse le idee che produciamo)
- sono essi stessi soggetti a distorsioni evidenti tutte loro (i limiti dei test sono ben noti, e i curricula per definizione sono documenti con finalità retorica)
- e, soprattutto, né gli uni, né gli altri possono raggiungere la vividezza, la coloritura e l’impatto emotivo che possiedono le impressioni generate da un’intervista di persona.
Come potete immaginare, non c’è gara, e l’impatto dell’intervista surclasserà tutti gli altri contributi (con i loro potenziali contributi correttivi).
Che fare? Kahneman e i suoi coautori sviluppano uno strumentario coerente per affrontare il problema del rumore nelle organizzazioni, a partire da quello che chiamano noise audit, un’analisi che permette di portare alla luce la sua presenza e i suoi costi nella specifica situazione. In attesa che questo nuovo approccio dia i suoi frutti (come è accaduto anni fa con l’idea di nudge) forse una buona idea è cominciare a sensibilizzare le proprie organizzazioni su questi temi. Se bias e rumore possono condizionare, nei processi di selezione, i professional dell’HR, figuratevi cosa può succedere con la presenza sempre più frequente e importante dei manager di business nei colloqui.
Una giornata dedicata ai bias potrebbe non essere una pessima idea.
from a photo by Daria Durand
