tempo di lettura 10′
Bazzico i bias cognitivi da un pezzo, ma questa non l’avevo ancora sentita. O meglio, non nella forma a metà tra l’accademico e lo sciamannato con cui è stata espressa. Sarà che il coronavirus produce creatività come effetto collaterale.
L’hanno chiamato Dunny Paper effect, e per una volta le tracce sembrano condurre non ai soliti Stati Uniti, ma alla lontana Australia (se non altro per il termine slang con cui è designato, effetto carta igienica).
Il 12 marzo il New York Times affronta di petto la questione: i social network testimoniano, con tanto di filmati, una corsa oceanica (nel senso dell’Oceania) all’aggiotaggio della carta da toilette, avanzando l’ipotesi che sia un fenomeno ormai internazionale (non sono personalmente al corrente di un simile panico igienico in Italia, ma non si sa mai. Noi, per testimonianza diretta, corriamo ad accaparrarci dosi da battaglione di farina e lievito: sarà una variante culturale?).
Razionalmente parlando, si tratta di una stupidaggine colossale. È l’unico vero modo per mettere in crisi una filiera che, secondo le autorità, continua a funzionare. I singoli individui, da un giorno all’altro, triplicano o quadruplicano le loro richieste di carta igienica, svuotando immediatamente i supermercati. I consumatori più razionali, prima o poi, finiscono le scorte personali, e si mettono a caccia dell’introvabile. Sospetto che i quotidiani possano godere di insperate impennate nelle vendite. I supermercati, a loro volta, sotto la pressione di una clientela assatanata e protestataria, magari ritoccano i prezzi, e intanto raddoppiano gli ordini ai grossisti, che in breve finiscono le scorte, e alzano la voce con i produttori. Questi, abituati da anni a trend di fabbricazione e smercio relativamente stabili, vengono posti sotto pressione per aumentare rapidamente la produzione: ma rapidamente, in fabbrica, non significa mai poche ore, e spesso neanche pochi giorni. Tra l’altro devono fare i conti con i loro fornitori, cosa che allunga ulteriormente i tempi di risposta. Risultato: per giorni e giorni i magazzini saranno vuoti e gli ordini si accumuleranno. Quando, alla fine, la accresciuta produzione riassortirà la catena distributiva, i supermercati, come i grossisti e le fabbriche, si troveranno sommersi di scorte di carta igienica, che i consumi, una volta tornati ai livelli di sempre, faranno fatica ad assorbire. Forse i negozi cominceranno a usarla per stampare gli scontrini.
Tutto questo è ben noto a chi si occupa di systems thinking, tanto da essere indicato con un nome, effetto Forrester, almeno dagli anni ’60 del secolo scorso.
Ma lasciamo perdere l’economia. Mi incuriosisce, invece, che il fenomeno confermi la mia tesi che la pandemia finirà per rivelarsi una ricca antologia, una collezione da manuale di quel tipo del tutto particolare di errori umani che prende il nome di bias cognitivi. Bias è un termine inglese che significa distorsione, polarizzazione. E bias cognitivi sono per l’appunto una lunga serie di distorsioni, di deviazioni dal giudizio e dal comportamento razionali, che ci troviamo a compiere, tutti quanti, praticamente in tutti gli ambiti della vita quotidiana e professionale.
A pensarci attentamente, la nostra giornata è assillata da decisioni -che cappotto compro per l’inverno- e micro-decisioni -con che piede scendo dal letto- che ci tocca prendere. Qualcuno ne ha calcolato il numero in oltre trentamila al giorno, che, anche a rinunciare al sonno, ridurrebbero il tempo per ragionarci a pochi secondi ciascuna. Se dovessimo trattarle secondo i dettami delle teorie razionali della decisione -seleziono le alternative, le valuto secondo una serie di dimensioni, valuto e peso le mie priorità, ecc.- non avremmo il tempo materiale per vivere. È proprio per una mera questione di sopravvivenza che, nel tempo, abbiamo elaborato – o l’evoluzione lo ha fatto per noi – una miriade di trucchetti, di scorciatoie mentali che sostituiamo al ragionamento per venire a capo di altrettante decisioni, senza perdere tempo, e senza sovraffaticare la nostra mente (la scienza le chiama euristiche). Alcune ce le hanno insegnate, o le abbiamo imparate dall’esperienza. Se incontriamo in una viuzza deserta uno sconosciuto, abbiamo imparato a osservare il vestiario, o la presenza di rigonfiamenti allarmanti nelle tasche, o la presenza di un passamontagna, per valutarne la pericolosità in assenza di altre informazioni. Altre scorciatoie potrebbero essere ormai acquisite per abitudine, e diventare una sorta di pilota automatico – cambio strada, o almeno marciapiede. Altre, infine, sono frutto dell’evoluzione, e le mettiamo in atto immediatamente senza pensarci, anzi inconsapevolmente (ad esempio, letteralmente leggiamo la configurazione dei muscoli facciali -l’espressione- o la postura, senza neanche sapere bene come siamo riusciti a farlo).
Per fortuna, queste scorciatoie, il più delle volte, funzionano. Se non funzionassero, mediamente, non saremmo sopravvissuti come specie e come singoli individui. Ma, come tutti gli attrezzi di una cassetta, ci sono circostanze in cui non funzionano. Un martello pneumatico va bene per rompere l’asfalto, non per tagliare il pane. Quando non funzionano, perché le applichiamo nel contesto sbagliato, ci portano a commettere errori. Questi errori sono quelli che chiamiamo bias.
Non si tratta di errori generici. Sono speciali. Per cominciare, siamo tutti soggetti ai bias. Quelli che, come me, li studiano, sono portati quanto chiunque altro a commetterli. Sono, dunque, universali. Sono anche sistematici: non sbagliamo una volta in un modo, una volta nell’altro, ma sempre nella stessa direzione, e sono quindi prevedibili. Infine, cosa più importante, spesso passano sotto il livello della nostra coscienza. Non ci accorgiamo di usare una scorciatoia. E, quando anche qualcuno ci faccia notare che ne abbiamo commesso uno, e lo riconosciamo, a posteriori proprio non hanno l’aria di essere errori. Sono lupi travestiti da agnelli.
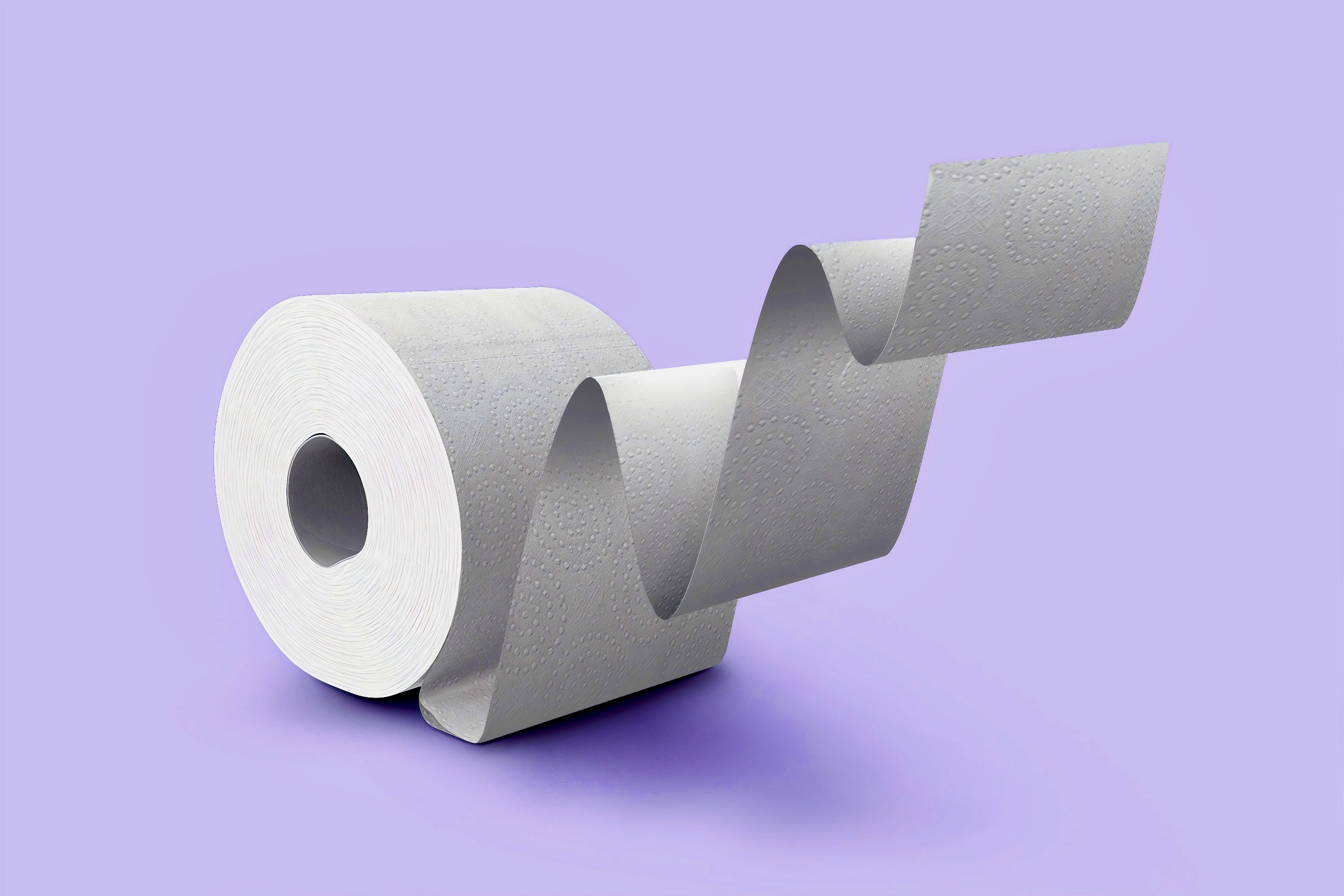
Fine della premessa teorica. Torniamo alla carta igienica.
La più gettonata tra le spiegazioni del panico cartaceo sembra essere quello che prende il nome di zero-risk bias. Si tratta della nostra tendenza ad accanirci sull’eliminazione totale di uno specifico rischio quando alternative meno monomaniacali ci consentirebbero di ridurre, pur non eliminando completamente, il rischio complessivo. Ottimizziamo un singolo aspetto del problema, sprecando risorse che potrebbero, allocate diversamente, migliorare sensibilmente il problema nel suo complesso. Lo vediamo in azione nelle persone ossessionate dal terrore per i cancerogeni alimentari, quando poi magari fumano, o consumano superalcolici, o conducono una vita stressante in una città altamente inquinata. Ma questo atteggiamento ha risvolti psicologici tranquillizzanti. Per cominciare, riduce la nostra ansia nei confronti del rischio, e aumenta la nostra sensazione (illusoria) di controllo su ciò che ci circonda. Due motori della nostra motivazione. Ridurre un rischio da 50% a 45%, o da 5% a 0, è cosa del tutto equivalente per un economista, ma assolutamente incomparabile per un umano in carne ed ossa. Anche se questo rischio è solo un piccolo frammento del rischio globale che corriamo. In più, ci dà la sensazione di avere agito nella direzione giusta; meglio che non fare nulla. In secondo luogo, pensare ad affrontare un problema nella sua interezza (in modo sistemico) è complesso, e, in termini cognitivi, faticoso. Quando dobbiamo ricorrere alla parte “raziocinante” della nostra mente, anche le persone più dinamiche diventano improvvisamente pigre, un dato di fatto con cui bisogna fare continuamente i conti quando parliamo di errori cognitivi.
Così, correre a fare incetta di carta igienica ci appare una scelta congrua: agiamo, ci portiamo avanti per le esigenze future, facciamo una cosa “fatta per bene”. “Ci appare”, in questi casi, è la parola chiave: anche se al supermercato affronteremo una folla di potenziali infetti, ci andiamo con gli amici – così è più divertente – e magari, all’uscita, ci fermiamo a chiacchierare nel giardinetto.
Ma ci sono altre piste concorrenti che potremmo seguire. In senso lato, siamo tutti animali sociali, aristotelicamente parlando. In senso più stretto: pure troppo, in alcune circostanze. Siamo tutti soggetti a un forte condizionamento da parte delle persone che ci circondano. A volte questa influenza si esprime nella forma di un intensa pressione sociale, spesso auto-indotta. Lo psicologo polacco Solomon Asch riuscì, in una serie di esperimenti famosi del lontano 1957, a far vedere ai soggetti come uguali segmenti di lunghezza manifestamente diversa, solo perché prima di loro cinque finti partecipanti, in realtà complici degli sperimentatori, avevano testimoniato che i segmenti erano identici. Forse dovrei togliere le virgolette al termine “vedere”, perché, in più recenti ripetizioni dell’esperimento, strumenti di brain imaging hanno mostrato modificazioni reali nelle aree cerebrali della percezione visiva. Che ci piaccia o meno, siamo soggetti al condizionamento da parte delle parole e dei comportamenti di chi ci sta intorno, a volte di proposito, più spesso inconsapevolmente. Questa propensione a piacere agli altri, o quanto meno a non dispiacere loro, è alla base di ciò che chiamiamo conformità, o conformismo.
Ma questo fenomeno ha anche altre ragioni, più strettamente informative, che sono state premiate nei millenni in termini evolutivi. Gli altri sono da sempre la nostra principale fonte di informazioni sul mondo. Così abbiamo sviluppato una scorciatoia mentale che usiamo più spesso di quanto crediamo: quando non sappiamo bene cosa fare, guardiamo cosa fanno gli altri. Semplice. Ma non sempre efficace. Così, accanto a informazioni corrette e utili, ci capita di assorbire, con la stessa intensità, informazioni sbagliate (uno dei meccanismi alla base delle fake news). Quando l’informazione poi circola in un gruppo di persone, l’effetto si amplifica. Provate a mettervi sul marciapiede, e guardare fisso un punto in alto, ad esempio un balcone di un palazzo. Finché siete da soli, probabilmente accadrà poco, o vi prenderanno per matto. Ma se cominciate a essere quattro o cinque persone, ben presto si accumulerà un gruppo di umani che guarderanno nella stessa direzione, prima in silenzio, poi probabilmente parlottando (è un tipo di trasmissione che aiuta lo sviluppo del panico, tra l’altro). Così, al supermercato, un affollamento intorno alla carta igienica, magari accompagnato da qualche alterco per accaparrarsi le ultime confezioni darà un chiaro segnale che si tratta probabilmente di una merce essenziale di cui forse non avremo altre occasioni di acquistare (pensateci, forse se foste stati soli nel magazzino non vi sarebbe neanche venuto in mente).
Questa proditoria cattura della vostra attenzione rientra nelle prerogative di un altro bias, uno dei più rilevanti nel panorama dei nostri errori, che prende il nome di availability bias (bias della disponibilità), che gioca a più livelli in questi fenomeni, cui accenno soltanto, in attesa di un’altra occasione per parlarne più estesamente. Detto in soldoni, quando non abbiamo basi troppo solide per rispondere a una domanda complessa (siamo nel bel mezzo di una carenza mondiale di carta igienica?), ci affidiamo alle memorie che più immediatamente ci vengono alla mente. Può essere l’immagine televisiva dell’assalto ai supermercati, o l’improvviso vuoto di scaffali una volta regolarmente pieni, o la telefonata di un amico che ha appena fatto una scorta da guerra. Specialmente se queste immagini o conversazioni sono venate da un impatto emotivo particolare (le emozioni facilitano la persistenza dei ricordi, e il loro recupero dalla memoria). Dov’è il problema? Lungi dal ricordarci semplicemente qualcosa che è utile sapere (non c’è nulla come sentire un andirivieni di sirene di ambulanza per ricordarci che c’è un coronavirus in agguato, come sta accadendo mentre scrivo), tendiamo a sovrastimare – spesso enormemente – la probabilità degli eventi che questi ricordi richiamano, sostituendo un giudizio ragionato e prudente con paura, o addirittura panico. A volte questo effetto passa dopo un po’ di tempo; spesso invece i ricordi si sommano, e diventano giudizi difficili da smontare (anche perché, per colpa di un altro bias, il confirmation bias, ricordiamo e ricerchiamo attivamente fatti che confermano le nostre tesi, scartando accuratamente quelli che tendono a smentirle. Ma questa è un’altra storia).
La lista potrebbe continuare, ma ci fermiamo qui. Non prima, però, di avere buttato lì un ballon d’essai assolutamente azzardato, ma suggestivo. Prendetelo come una battuta. No, non parlo di Freud e dei suoi ovvi riferimenti all’argomento.
Piuttosto, per restare nell’ambito delle scienze cognitive, a quel bizzarro fenomeno che qualcuno ha chiamato Lady Macbeth effect. Il personaggio shakespeariano, dopo avere spinto il marito a commettere regicidio, diventando così regina di Scozia, dapprima intinge essa stessa le mani nel sangue del cadavere, rampognando la codardia del coniuge (“Le mie mani sono del colore delle vostre, ma io mi vergognerei riavere il cuore bianco come voi”, e poi “un po’ d’acqua ci farà mondi di quest’atto”). Ma, nella pazzia che la porterà (forse) al suicidio, continuerà a vedere indelebili macchie di sangue sulle proprie mani.
Il Lady Macbeth effect rappresenta la tendenza, quando sentiamo una “macchia nelle nostre anime”, a desiderare di pulire il nostro corpo. E in maniera molto specifica, oltretutto. In un esperimento, le persone a cui veniva chiesto di mentire a una persona immaginaria per telefono o via email, rispondevano in modo differenziato a un successivo test di gradimento su prodotti igienici. Coloro che avevano mentito per telefono tendevano nettamente a preferire dentifrici ai saponi per le mani; i mentitori via email, al contrario, mostravano preferenze invertite.
Che abbiano ragione i profeti che sostengono che il coronavirus è la risposta della Terra ai nostri peccati?
photo by Morning Brew
